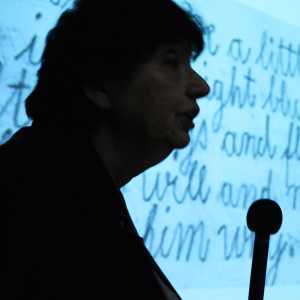Ben Kingsley
27 gennaio 2015, Terezín
La presenza di sir Ben Kingsley a Terezín è stata merito dello European Jewish Congress e della produzione esecutiva di PalazziGas Events, che hanno dato vita al quarto forum internazionale «Let my people live!»
«Il senso della conoscenza esiste forse in questa vicinanza, nell’idea che noi che non c’eravamo non potremo mai capire da dentro cosa accadde qui a Terezín. Potremo solo ascoltare, volare vicini, avvicinarci alla verità e alle parole che ci rimangono per ricordare». Le parole sono quelle che il noto attore Ben Kingsley ha letto nel Giorno della Memoria proprio lì, a Terezín, in quell’angolo di Praga dove durante la seconda guerra mondiale vennero internate centinaia di persone e al quale lo scrittore Matteo Corradini ha dedicato un libro onesto e tenero quale è La repubblica delle farfalle. A scriverle è stato proprio l’ebraista italiano, a cui è spettato il compito di scrivere il testo di commemorazione del 27 gennaio letto da Kingsley.
«Terezín prova a riempire noi delle sue storie» si legge nel discorso, «e per qualche attimo misterioso, se sapremo ascoltarle, non saremo più presidenti, personalità, attori celebri: saremo solo esseri umani. E dunque fragili». Quelle storie Corradini le ascolta da ormai 12 anni, ossia da quando ha iniziato a interessarsi alla storia e alle storie di Terezín. «Quando ero in quinta superiore, ci avevano portati a vedere Schindler’s List: non so se quel film abbia cambiato il mio futuro, ma certamente mi aprì gli occhi su un modo diverso di lavorare, mi fece capire che la Shoah poteva essere raccontata attraverso la bellezza delle persone» ha spiegato Corradini, commentando l’evento del Giorno della Memoria, «quando Itzhak Stern, ossia il personaggio che Kingsley interpretava, alza con una mano la lista di Schindler e con l’altra mima un cerchio dicendo che lì, nella lista, c’era la vita, e tutto intorno la morte, rende chiarissimo il significato del mio lavoro: ricostruire e raccontare l’esistenza di chi non esiste più, di chi è solo un nome agli occhi di tutti, un numero sopra un elenco di gente trasportata, una data di arrivo in un lager, una stellina di pezza gialla cucita con sei punti al cappotto. Ventun’anni dopo, mi sono ritrovato a stringere la stessa mano».
«Nel ghetto di Terezín, entrambi quel giorno siamo stati solo dei servitori: i protagonisti nei nostri cuori erano le ragazze e i ragazzi ebrei partiti da lì e uccisi ad Auschwitz, e i pochissimi sopravvissuti, ora invecchiati e stanchi, davanti a noi nelle prime file. Da sconosciuto come me è più semplice mettersi al servizio, e in questo sir Ben è stato davvero grande: a Terezín non ha fatto la star, ha affrontato la giornata gelida con grande amore per le parole che stava per pronunciare, ha stupito per la dedizione e l’umiltà. S’è tolto la cuffietta nera che lo proteggeva e via, è stata solo commozione. Nel buio sceso su Terezín, con le giacche ghiacciate, gli ultimi fari che illuminavano la menorah in pietra del cimitero e la security, così tanto presente quel giorno dopo gli episodi francesi, a circondarci: ci siamo salutati abbracciandoci, persuasi d’aver acceso una lucina, seppur minuscola, nel nero di quella notte».
Il discorso di Ben Kingsley
Ben Kingsley’s speech
Siamo sotto le coperte nella camerata. Terezín, casa L417 stanza numero Uno. I letti a castello hanno smesso di cigolare, i bambini piccoli, che la sera piangono di più, hanno preso sonno. Ma noi siamo grandi, abbiamo tredici, quattordici e quindici anni, non badiamo più a queste cose. O siamo solo più bravi a tacerle e a reprimerle. Ora tutti dormono. Esco dalle coperte lentamente come la farfalla che si fa largo dal bozzolo per rinascere, ho la faccia della farfalla, la leggerezza della farfalla e la voglia della farfalla. I miei colori li porto nelle mani, non sulla pelle, ho la bellezza della farfalla ma tutta nel palmo. Le mie ali sono quei fogli che nascondo sotto il materasso. Sollevo il peso dolcemente, sfilo le pagine bianche e le pagine degli appunti. Cammino scalzo. Io sono una farfalla. (Matteo Corradini, La repubblica delle farfalle)
È strano dirlo, ma qui a Terezín ci è chiesto di volare. Nonostante il freddo e il ricordo, ci è chiesto di volare esattamente come è chiesto alle farfalle: fragili, vicine, colorate.
Qui nel ghetto più a ovest di tutti i ghetti, qui nell’ultimo ghetto che è stato liberato, stasera ci sentiamo fragili. Percepiamo che l’umanità dolorosa che attraversa questa terra, gli alberi, i muri, i sassi, l’aria, forse sta attraversando anche noi. Terezín prova a riempire noi della sue storie, e per qualche attimo misterioso, se sapremo ascoltarle, non saremo più presidenti, personalità, attori celebri: saremo solo esseri umani. E dunque fragili.
Ilse Weber era un’ebrea ceca e finì a Terezín con il marito e il figlio più piccolo. Il figlio più grande lo aveva salvato un Kindertransport, poco tempo prima. Ilse fu messa in servizio nell’infermeria dei bambini: visse l’angoscia per il figlio più piccolo, la nostalgia per quello più grande, e scrisse canzoni e poesie per i bambini ammalati, perché si addormentassero più sereni alla sera. Una sua ninna nanna dice: «La luna è una lanterna, e guarda il mondo dall’alto». Chissà cosa vede ora la luna, del nostro mondo. Chissà cosa ne pensa.
Oggi ci accompagnano i sopravvissuti presenti tra di noi: possiamo guardarli in faccia, sono qui. Ci accompagnano anche i tanti, e sono la maggior parte, che da qui sono passati e non hanno fatto più ritorno alle loro città.
In questo imbrunire freddo che poco a poco ci avvolge, abbiamo nella mente le notti di Ilse che metteva a letto i bambini, come se in quelle notti ci fossero le notti di tutti gli ebrei che soffrirono nel ghetto. Abbiamo nella mente l’imbrunire delle vite, le attese dei treni che partivano verso i campi di sterminio, il passaggio delle ceneri dei giustiziati che venivano portate anche lungo questa strada, dove siamo ora. Ma è mai finita per davvero quella notte?
Pensiamolo adesso, stasera. Proviamo a stare vicini alla storia. Vicini come volano vicine alla terra le farfalle: il senso della conoscenza esiste forse in questa vicinanza, nell’idea che noi che non c’eravamo non potremo mai capire da dentro cosa accadde qui a Terezín. Potremo solo ascoltare, volare vicini, avvicinarci alla verità e alle parole che ci rimangono per ricordare.
E farlo qui a Terezín, dove le parole volevano sempre dire altro, dove il lavoro non era lavoro ma schiavitù, dove il pane non era pane, e il caffè non era caffè. Perfino la vita fingeva di essere se stessa: la violenza nazista qui a Terezín si è espressa anche sotto la forma di una diabolica menzogna, che trasformava i nomi, trasformava le cose.
Vi ricordate del Madagascar? I nazisti dicevano che vi avrebbero condotti gli ebrei, che sarebbe diventata la loro nazione. Naturalmente era tutta una falsità, non è mai esistito un progetto preciso e realizzabile perché le parole, per i nazisti, significavano sempre altro: Madagascar voleva dire deportazione, Madagascar voleva dire Terezín. Terezín voleva dire Auschwitz. E Auschwitz voleva dire morte.
All’interno della catena della Shoah, il significato vero di ogni luogo risiedeva nel luogo successivo. Qui a Terezín, Peter Ginz vi scrisse un articolo sul giornale clandestino che dirigeva, Vedem. Diceva: «Ogni oggetto, quando viene in contatto con l’umanità, è come una maledizione». Peter aveva compreso il male generato dai nazisti, un male che penetra nelle cose, che non passa, che resiste perfino alla sconfitta del Terzo Reich. Non basta il tempo ad annullarlo. È importante chiederci cosa rimanga tra di noi, di questo male, e aprire i nostri occhi sul presente: i nazisti hanno perso la guerra, d’accordo, ma il loro male è stato davvero sconfitto?
Noi siamo il ghetto; se il ghetto si salva, ci salviamo tutti. È l’idea che sostenne le molte forme di resistenza che sono nate a Terezín. La salvezza passa attraverso l’unione, e la cultura nel ghetto ha permesso agli ebrei di saldare le forze e trovare identità. Pur immersi nella maledizione di questo luogo, i ragazzi di Terezín hanno prodotto giornali clandestini, hanno scritto poesie, hanno cantato nella straordinaria opera Brundibár, della quale tra poco ascolteremo la musica e le parole.
Di solito ai ragazzi si insegna: «Non dire le bugie». Ma contro la finzione violenta creata dai nazisti, i ragazzi di Terezín hanno dovuto reagire con una bugia più bella, seppur più fragile: l’arte. A tutte le età hanno compreso che raccontare quello che vedi non salverà il tuo corpo, ma farà in modo che la tua fantasia possa vivere nella vita di un altro, dopo di te, anche solo per un minuto.
Quanto dura la vita di una farfalla? Come farfalle, gli ebrei hanno composto ed eseguito musica, hanno disegnato e dipinto, hanno recitato e messo in scena, hanno insegnato e imparato: la cultura qui a Terezín ha rappresentato l’ultimo fragile legame con la propria umanità, è come un filo che coraggiosamente non è stato tagliato. Solo 142 ragazzi e bambini sopravvissero alla Shoah: le loro storie, insieme a mille altre storie, possono rivivere dentro di noi. Fragili, vicine, colorate. Come farfalle.